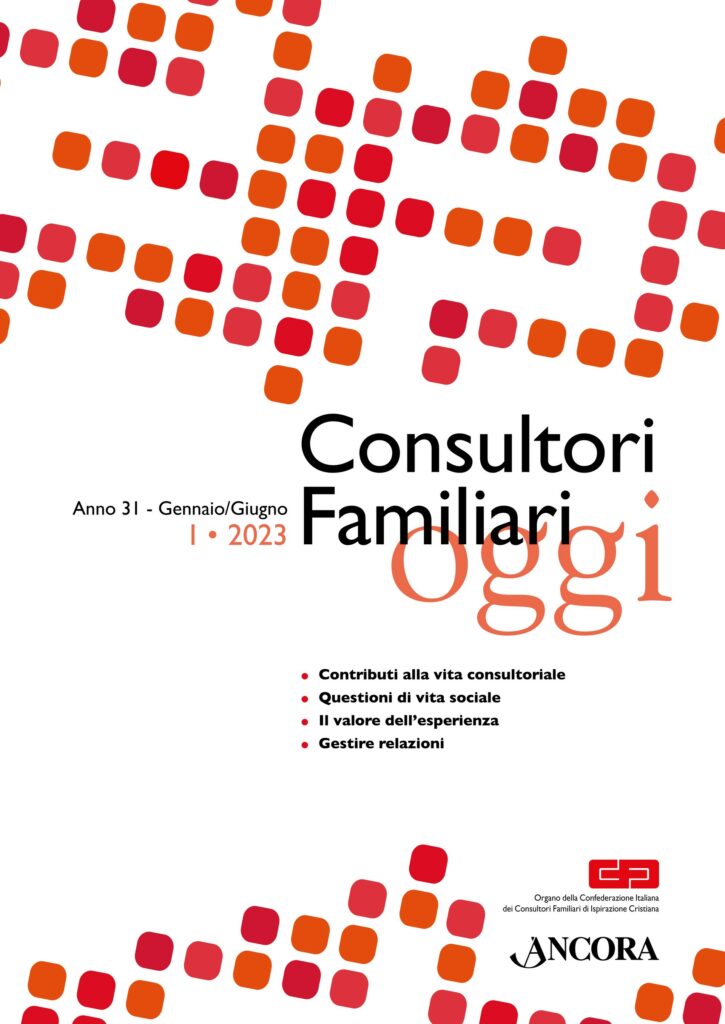CONTRIBUTI ALLA VITA CONSULTORIALE
La categoria pedagogica dell’ascolto acquista particolare rilievo all’interno della prospettiva paideutica della Philosophy for children. La comunità di ricerca, radicata nella centralità del dialogo ascoltante, offre ai bambini la possibilità di coltivare la loro naturale attitudine speculativa, dando così voce all’infanzia e ai suoi bisogni evolutivi, emotivi e cognitivi. L’intento del contributo è quello di indagare l’item dell’ascolto ermeneutico e discernitore nell’àmbito dei percorsi ideati da M. Lipman, mediante il ricorso a racconti filosofici scritti ad hoc, nel rispetto di metodologie adeguate alle diverse età e di un’ottica inclusiva. Pur non avendo l’Autore teorizzato questo tema all’interno del suo curricolo, esso può essere rintracciato attraverso una lettura attenta dei materiali che danno vita a tale programma americano. Pertanto, l’obiettivo è proprio quello di rendere esplicite la centralità e la valenza educativa della dimensione ascoltante nella Philosophy for children, ai fini di un’educazione al pensiero critico.
The pedagogical category of listening takes on particular importance within the educational perspective of Philosophy for children. The research community, rooted in the centrality of a dialogue of listening, gives children the opportunity to cultivate their natural speculative attitude, thus giving a voice to childhood and its developmental, emotional and cognitive needs. The aim of the paper is to investigate the item of hermeneutic and discerning listening in the context of the paths devised by M. Lipman, through the use of philosophical stories written for this purpose, in line with methodologies suitable for different age groups and an inclusive perspective. Although the Author has not theorized this theme within her curriculum, it can be traced through a careful reading of the materials that give life to this American programme. Therefore, the goal is precisely to elucidate the centrality and educational value of the dimension of listening in Philosophy for children, for the purpose of education to critical thinking.
Dans toutes les trajectoires existentielles et à tout âge de la vie, des événements défavorables peuvent survenir, face auxquels les réactions sont multiples et diversifiées. Certaines personnes peuvent succomber au traumatisme vécu, tandis que d’autres font face à la situation en mettant en place leur propre résilience. La résilience apparaît comme un concept extrêmement complexe, qui mérite une attention particulière. La contribution prend pour point de départ une analyse historique du concept, et arrive à une définition du processus de résilience, en mettant en garde contre d’éventuels malentendus du terme. Une vision dynamique de la résilience émerge qui profite du contexte relationnel et des liens affectifs et cognitifs établis avec l’environnement voisin. On ne devient pas résilient tout seul. Résilience et relation sont indissociables pour faire face à la souffrance.
In tutte le traiettorie esistenziali e ad ogni età della vita possono insorgere degli eventi sfavorevoli, di fronte ai quali le reazioni sono plurime e diversificate. Alcune persone possono soccombere al trauma vissuto, altre invece affrontano la situazione mettendo in campo la propria resilienza. La resilienza appare un concetto estremamente complesso, che merita un particolare approfondimento. Il contributo muove da un’analisi storica del concetto, per giungere ad una definizione del processo di resilienza, mettendo in guardia da possibili fraintendimenti. Emerge una visione dinamica della resilienza che trae vantaggio dal contesto relazionale e dai legami affettivi e cognitivi stabiliti con l’ambiente vicino. Non si diventa resilienti da soli. Resilienza e relazione sono inseparabili per affrontare la sofferenza.
Con la Lettera Apostolica ‘Mitis iudex’ emanata il 15 agosto 2015 l’attuale Pontefice apporta incisive modifiche alle norme del Codice canonico riguardanti il processo matrimoniale, allo scopo di rendere più accessibili e agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità del matrimonio. Auspica l’istituzione in ogni diocesi di strutture idonee a rendere un servizio di informazione, di consiglio e di mediazione a persone separate o a coppie in crisi in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale. Ne discende l’opportunità di valorizzare l’attività dei Consultori di ispirazione cristiana o di stampo cristiano che, istituzionalmente dediti alla cura delle problematiche familiari, sono organismi competenti a svolgere un ruolo di sostegno e di accompagnamento nella fase propedeutica al processo.
With the Apostolic Letter ‘Mitis iudex’ issued on 15 August 2015, the current Pontiff makes important changes to the norms of the Canon Code concerning the matrimonial process in order to make the procedures for recognising cases of marriage nullity more accessible and agile. The Pontiff calls for the establishment in each diocese of structures suitable to render an information, counselling and mediation service to separated persons or couples in crisis with a view to the preliminary investigation of the matrimonial process. The opportunity arises to enhance the activity of Christian or Christian-inspired Consultatories which, institutionally dedicated to the care of family problems, are competent to play a supportive and accompanying role in the preparatory phase of the process.
QUESTIONI DI VITA SOCIALE
La famiglia si attende dalla società prima di tutto di essere riconosciuta nella sua identità e accettata nella sua soggettività sociale. Riconoscere la famiglia come soggetto sociale, portatore di interessi propri e specifici, nonché titolare di compiti educativi e di responsabilità sociali, è il primo passo per un Paese che intenda investire sul capitale relazionale e sociale, per offrire uno sguardo radicato al presente e orientato al futuro. La realtà ci insegna che in Italia questo ‘riconoscimento’ non è mai avvenuto negli ultimi decenni e che le famiglie hanno dovuto far fronte alle complessità della nostra epoca in pieno abbandono da parte dei policy maker. La grave e cronica crisi di denatalità, che affligge il nostro Paese e che ne compromette il futuro, ha radici che partono da lontano e rappresenta un sintomo di un malessere che merita di essere considerato in tutta la sua complessità. Indossare gli ‘occhiali della famiglia’ e attivare politiche familiari propriamente dette e nettamente differenziate dalle politiche di ‘lotta alla povertà’, è il cambio di paradigma improrogabile che sono chiamate ad attivare la politica, l’amministrazione ed i corpi sociali intermedi del nostro Paese.
The family expects from society first of all to be recognized in its identity and accepted in its social subjectivity. Recognizing the family as a social subject, bearer of its own and specific interests, as well as holder of educational tasks and social responsibilities, is the first step for a country that intends to invest in relational and social capital, to offer a look rooted in the present and oriented towards the future. Reality teaches us that in Italy this ‘recognition’ has never occurred in recent decades and that families have had to face the complexities of our age in full abandonment by policy makers. The serious and chronic crisis of denatality, which afflicts Italy and which compromises its future, has roots that start from afar and represents a symptom of a malaise that deserves to be considered in all its complexity. Wearing ‘family glasses’ and activating properly so-called ‘family policies,’ clearly differentiated from the ‘fight against poverty’ policies, is the imperative paradigm change that is called upon to activate politics, administration, and intermediate social bodies of the country.
Il termine ricerca inclusiva è usato in letteratura per descrivere una partnership tra accademici e persone con disabilità intellettive, realizzata allo scopo di condurre insieme la ricerca. Questo tipo di partenariato deve contenere alcuni elementi chiave, come affrontare le questioni che interessano le persone con disabilità intellettive, ed essere condotto con rispetto e in un modo tale da consentire alle persone con disabilità intellettive di presentare le proprie opinioni ed esperienze nella ricerca. Il presente articolo si basa su un ‘case’ in cui, per la prima volta in Norvegia, una persona con sindrome di Down ha partecipato attivamente come co-ricercatore a un progetto di ricerca sull’educazione della prima infanzia. L’obiettivo era aumentare la competenza dei ricercatori riguardo alla capacità di includere tutti i bambini in un’attività ludica con un robot nella prima infanzia. Questo articolo è stato scritto in collaborazione tra due ricercatori, il co-ricercatore e la sua persona di contatto. Il presente lavoro sottolinea l’importanza della ricerca inclusiva, mostrando la conoscenza unica che una persona con disabilità intellettiva può apportare a un progetto di ricerca sull’inclusione. L’articolo analizza il metodo sviluppato nel nostro caso di ricerca inclusiva attraverso la lente della teoria di H. Skjervheim. I risultati evidenziano che tutti e tre gli elementi principali della teoria sono stati realizzati: comunicazione simmetrica, partecipazione degli utenti e cooperazione con le persone di contatto.
The term inclusive research is used in literature to describe a partnership between academics and people with intellectual disabilities, with the aim of conducting research together. This type of partnership must contain some key elements, such as addressing issues that matter to people with intellectual disabilities, and being conducted with respect and in a way that allows their views and experiences to be given weight in the research. The present article is based on a case in which, for the first time in Norway, a person with Down Syndrome has participated actively as co-researcher in a research project about early childhood education. The aim was to increase the researchers’ competence in relation to how to include all the children in an activity with a coding toy in Early Childhood Education and Care. This article is written in a partnership between two researchers, the co-researcher, and her contact person. This underlines the importance of inclusive research, showing the unique knowledge that a person with an intellectual disability can bring to a research project about inclusion. The article analyses the method developed in our case of inclusive research through the lens of Skjervheim’s theory. Results highlight that all three main elements of the theory have been realized – symmetric communication, user participation and contact person cooperation.
IL VALORE DELL’ESPERIENZA
Nella primavera 2021 la Fondazione don Silvano Caccia ha promosso un’azione di ascolto degli adolescenti e preadolescenti del territorio comasco e lecchese. Ciò che è stato indagato è il benessere relazionale e affettivo dei ragazzi e delle ragazze in seguito al lungo periodo di restrizioni iniziato nel marzo 2020. I dati raccolti e i risultati di sintesi riportati nel presente contributo relativamente alla relazione con se stessi, alle relazioni familiari e tra pari e all’esperienza scolastica compongono un mosaico di riflessioni possibili sull’esperienza vissuta sottolineando l’importanza di un ripensamento comunitario dell’azione educativa e di cura.
In spring 2021, the Don Silvano Caccia Foundation started a project aimed at interviewing the adolescents and pre-adolescents living in the Como and Lecco area. What has been investigated concerns the relational and emotional well-being of boys and girls following the long period of restrictions that began in March 2020. The data collected and the summary results reported in this paper focus in particular on the adolescents’ relationship with the self, family and peers and on their scholastic experience. The information gathered in this report sparkles a reflection on their experience, stressing the importance of reimagining educational and welfare issues in a social context.
L’ascolto dei minori e degli adulti vulnerabili che hanno subìto un abuso (sessuale, psicologico, di potere o di coscienza) nella Chiesa, rappresenta un tema di grande rilevanza ed importanza. È necessario favorire, oggi, una cultura dell’ascolto empatico delle vittime attraverso un percorso di accoglienza, ascolto, accompagnamento, al fine di favorire un autentico cammino di guarigione delle vittime all’interno della comunità cristiana. L’ascolto delle vittime necessita di una previa e permanente formazione integrale ed integrata di coloro che sono preposti a questo delicato servizio nella Chiesa. A tal proposito, acquistano particolare rilevanza i centri di ascolto e i servizi di accompagnamento delle vittime che si pongono al confine tra accoglienza, assunzione di responsabilità e accountability. Il presente contributo si prefigge l’obiettivo di studiare tale tematica seguendo un approccio multidisciplinare e pluridisciplinare a partire da quello giuridico-canonico.
Listen to underages and vulnerable adults who have suffered abuse sexual, psychological, power or conscience) in the Church, represents a topic of great significance and importance. It is necessary to favor, today, one culture of empathic listening to victims through a process of reception, listening, accompaniment, in order to favor an authentic journey healing of victims within the Christian community. Listening to the victims requires prior and ongoing integral training and integrated by those who are in charge of this delicate service in the Church. In this regard, the listening centers acquire particular importance and the accompanying services for victims who arrive at the border between acceptance, assumption of responsibility and accountability. The present contribution aims to study this issue following an approach multidisciplinary and pluridisciplinary starting from the juridical-canonical one.
GESTIRE RELAZIONI
In questo articolo si tenta di esplorare i nodi del crescere legati all’adolescenza, a partire dall’esperienza vissuta con i ragazzi, e dalla narrazione che essi stessi fanno della loro vita. Un tema complesso, soprattutto in un tempo come il nostro, dove la pandemia ha smascherato le più o meno latenti fragilità dell’educare. Senza la pretesa di essere esaustivi, si ritiene necessario poter almeno accennare ad alcuni elementi da valorizzare o sistematizzare nell’agire pedagogico. In particolare, l’intento è di tratteggiare un modo di riorientare l’educare secondo una prospettiva sistemica, dove la famiglia e le altre agenzie educative siano in grado di mettersi in dialogo per creare una solida cornice di senso che sappia contenere, sostenere e aiutare ad interpretare i bisogni emergenti nei ragazzi e nelle ragazze del nostro tempo. Al centro il complesso mondo delle emozioni e dei sentimenti, la cui educazione è necessaria a fornire strumenti per costruire relazioni orientate al rispetto di sé e dell’altro da sé.
This article aims to explore the problems that emerge during adolescence, starting from the experience of having lived in close contact with adolescents and from how they look and talk about their own lives. This a complex issue, especially nowadays, when the pandemic has exposed the hidden fragility of education. At the same time, we consider it necessary, making no claim to be exhaustive, to mention some elements of the pedagogical system so as to systematize them or enhance their value. In particular, the aim of the article is to outline a way of rethinking education according to a systemic perspective, where the family and other educational components should be able to talk to create a solid framework of meaning that can contain, support, and help to interpret the emerging needs of the boys and girls of our time. The focal point of the issue is the complex world of emotions and feelings, whose education is necessary to provide adequate tools to build relationships based on respect for oneself and others.
Nel counseling sessuologico si considera spesso l’etica religiosa tra i fattori che, potenzialmente, interferiscono sulla capacità di esprimersi liberamente e, in ultima analisi, sul benessere sessuale. Certo, sarebbe sbagliato se il piano etico personale del counselor influenzasse l’intervento sessuologico, ma nemmeno si può pretendere che egli si svesta delle sue convinzioni personali, della sua fede o della sua visione etica, che restano inscindibilmente unite alla competenza umana e professionale. Sarebbe innaturale e altrettanto negativo, ma anche impossibile nella pratica. Ma allora come armonizzare professionalità e fede nell’intervento sessuologico? Rispettando le convinzioni personali, religiose o morali di ciascuno, l’etica cristiana e la Gestalt Therapy possono costituire, in àmbito sessuologico, un terreno comune ed efficace. L’etica cristiana si basa, infatti, su una visione della sessualità estremamente positiva, mentre la Gestalt Therapy si ispira a princìpi profondi (la teoria del campo, l’analisi dei fenomeni, la relazionalità, la totalità organismica), a tratti spirituali, che orientano alle maggiori consapevolezza, libertà e responsabilità.
In sexological counseling, religious ethics are often considered among the factors that potentially interfere with the ability to express oneself freely and, ultimately, with sexual well-being. Of course, it would be wrong if the counselor’s personal ethical plan influenced the sexological intervention, but neither can it be expected that he undresses his personal convictions, his faith or his ethical vision, which remain inseparably linked to human and professional competence. It would be unnatural and just as bad, but also impossible in practice. But then how to harmonize professionalism and faith in sexological intervention? By respecting the personal, religious or moral beliefs of each, Christian ethics and Gestalt Therapy can constitute, in the field of sexology, a common and effective ground. In fact, Christian ethics is based on an extremely positive vision of sexuality while Gestalt Therapy is inspired by profound principles (the theory of the field, the analysis of phenomena, relationality, the organismic totality), at times spiritual, which guide the more awareness, freedom and responsibility.
Il contributo intende analizzare, pedagogicamente, il ruolo della persona anziana e, in particolare, il rapporto educativo che intercorre, all’interno della famiglia, tra i nonni e i nipoti. La famiglia è la prima cellula costitutiva della società dove nell’amore è generata la vita e giorno dopo giorno è alimentata nella crescita e nell’educazione filiale. Ciascuna soggettività, per poter crescere e svilupparsi armonicamente, ha bisogno di essere riconosciuta nelle sue peculiari caratteristiche. Nell’infanzia il bambino riceve, attraverso raffinate e complesse dinamiche relazionali con le figure genitoriali e con i nonni, un imprimatur di riconoscimento. Continuamente l’essere umano si costituisce in quanto tale, scoprendosi e ascendendo, progressivamente, alla conoscenza delle sue peculiarità e caratteristiche che lo rendono persona, attraverso l’altro, nella relazione. La narrazione delle storie di vita vissuta declina spesso l’esistenza degli anziani, come se il racconto fosse funzionale all’educĕre, operazione maieutica e trasformativa dell’interiorità. All’interno della famiglia vengono trasmesse memoria, esperienze, vissuti che rendono i nonni indispensabili testimoni di vita vissuta, educatori ante litteram, in un’epoca come la nostra segnata drammaticamente dalla superficialità e dall’oblio. I nonni nel microcosmo familiare rimangono costantemente aperti all’ascolto ed al dialogo con i nipoti, che nella quotidianità frenetica e massificata, non trovano talvolta l’autentica disponibilità degli adulti. I nonni riescono spontaneamente a calibrare la vicinanza e la distanza relazionandosi con i nipoti con spontaneità e consapevolezza. La condizione più autentica e feconda dei nonni all’interno della famiglia è quella di mediatori e di educatori capaci di mostrare ai nipoti l’esistenza di un patrimonio valoriale da riscoprire e da riproporre. Coltivando attraverso l’educazione i valori perenni dell’esistenza della persona insieme agli altri, le qualità fondamentali da acquisire in un mondo bisognoso di solidarietà e di amicizia sociale, di attenzione alle persone più che alle cose.
The contribution intends to analyze, pedagogically, the role of the elderly person and, in particular, the educational relationship that exists, within the family, between grandparents and grandchildren. The family is the first constitutive cell of society where life is generated in love and day after day it is nourished in growth and filial education. Each subjectivity, in order to grow and develop harmoniously, needs to be recognized in its characteristic peculiarities. In childhood, the child receives, through refined and complex relational dynamics with parental figures and grandparents, an imprimatur of recognition. The human being continuously constitutes himself as such, discovering himself and progressively ascending to the knowledge of his peculiarities and characteristics that make him a person, through the other, in the relationship. The narration of real life stories often declines the existence of the elderly, as if the story were functional to education, a maieutic and transformative operation of the interior. Within the family, memories, experiences are transmitted that make grandparents indispensable witnesses of real life, educators ante litteram, in an era like ours dramatically marked by superficiality and oblivion. Grandparents in the family microcosm remain constantly open to listening and to dialogue with their grandchildren, who in the hectic and standardized daily life sometimes do not find the authentic availability of adults. Grandparents spontaneously manage to calibrate proximity and distance by relating with their grandchildren with spontaneity and awareness. The most authentic and fruitful condition of grandparents within the family is that of mediators and educators capable of showing grandchildren the existence of a heritage of values to be rediscovered and re-proposed. By cultivating through education the perennial values of the person’s existence together with others, the fundamental qualities to be acquired in a world in need of solidarity and social friendship, of attention to people more than to things.
CONTRIBUTI ALLA VITA CONSULTORIALE
L’educazione della libertà responsabile, in un contesto multiculturale e spesso fluido come quello attuale, esige un metodo che parta dall’esperienza del soggetto e che arrivi all’integrazione delle diverse dimensioni della sua persona: quella razionale, quella emotiva e quella volitiva. L’articolo propone un metodo di “rilettura delle esperienze e delle decisioni” che favorisca l’ottenimento di tali obiettivi cercando di riconoscere e valorizzare in esse i seguenti punti: il riconoscimento di un bene concreto, la capacità di riconoscere alternative e costi impliciti nella scelta, la presenza di una triplice apertura: a sé stessi, agli altri e all’orizzonte dei valori assoluti. La presenza di questi fattori normalmente genera a livello affettivo i sentimenti di contentezza e di fierezza, che a loro volta sostengono la determinazione a portare avanti le proprie decisioni seguendo una pianificazione realistica, perseverando fedelmente fino alla fine, usando i mezzi appropriati.
The education of responsible freedom, in a multicultural and often fluid context like the current one, requires a method that starts from the subject’s experience, and then aims at the integration of the different dimensions of his person: the rational, the emotional and the volitional. The present article proposes a method of “reviewing experiences and decisions” which favors the achievement of these objectives by trying to recognize and enhance the following points: the recognition of a concrete good inherent in any decision, the ability to recognize alternatives and costs in the decision taken, the presence of a threefold openness: to oneself, to others and to the horizon of absolute values. These factors normally awaken in the subject the feelings of contentment and pride. The latter, in their turn, enhance the determination of the subject to carry out one’s decisions following a realistic planning, persevering faithfully to the end, using the appropriate means.
In un tempo segnato dalla complessità e fluidità del quotidiano, di particolare rilevanza è l’approfondimento, in prospettiva teorica e pratica, delle modalità che sollecitano un giovane ad avviare e mantenere un percorso di volontariato attivo. Per addentrarsi nella riflessione, il Centro studi sul volontariato e la partecipazione sociale (CESVOPAS) dell’Università Cattolica della sede di Brescia ha affiancato un gruppo di giovani di un’Organizzazione di Volontariato del territorio limitrofo, allo scopo di avviare una prima indagine esplorativa in merito a motivazioni, rappresentazioni, azioni e valori propri dell’attivazione volontaristica. A partire dalla letteratura esistente sull’engagement, il contributo intende esaminare come esso si esprima nel volontariato giovanile e in che modo concorra alla formazione e al perfezionamento della persona e al progredire della comunità locale.
In a time marked by the complexity and fluidity of everyday life, we would like to stress the process of deepening, in theoretical and practical perspective, of the ways that urge a young person to start and maintain an active volunteer path. To get into the reflection, the Study Centre on Volunteering and Social Participation (CESVOPAS) of the Catholic University in Brescia has joined a group of young people from a Volunteer Organization of the surrounding area, in order to launch first exploratory research into the motivations, representations, actions and values of voluntary activation. Starting from the existing literature on engagement, the contribution aims to examine how it expresses itself in youth volunteering and how it contributes to the formation and improvement of the person and the progress of the local community.
Il presente contributo è in continuità con un articolo precedentemente pubblicato nel 2020 su Consultori Familiari Oggi e illustra i rapidi sviluppi che nell’arco di pochi anni d’intensa attività di ricerca sul Family Impact Lens hanno portato dapprima a registrare nel 2020 il marchio FamILens® da parte del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia e, successivamente, a riconnettere il filone di studi sulla qualità relazionale e familiare dei servizi e sulle buone pratiche con l’analisi dell’impatto familiare, portando a ipotizzare un nuovo modello, il FamILens.COM, in cui la capacità di impattare positivamente sulle relazioni familiari risulti essere l’obiettivo primario e il carattere distintivo delle best practices nei servizi alla persona.
This contribution is in continuity with an article previously published in 2020 in Consultori Familiari Oggi. It illustrates the rapid developments that, in the space of a few years of intense research activity on the Family Impact Lens, have led first to the registration in 2020 of the FamILens® trademark by the Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia and subsequently to the reconnection of the strand of studies on the relational and family quality of services and on best practices with family impact analysis: this led to hypothesize a new model, the FamILens.COM, in which the ability to positively impact on family relationships appears to be the primary objective and distinctive character of best practices in human services.
QUESTIONI DI VITA SOCIALE
Quanto accaduto durante il periodo pandemico, in termini di solitudine e isolamento sociale, ci ha reso più consapevoli dell’importanza delle relazioni sociali esterne alla famiglia, sia per il benessere dei singoli componenti delle famiglie, sia per l’intero nucleo. Costruire àmbiti di comunità e prendere parte attiva a tali processi è un compito sociale cruciale che le famiglie possono svolgere contribuendo in tal modo alla realizzazione di contesti sociali attenti ai bisogni delle persone e nei quali sia possibile esperire scambi di reciprocità, di cooperazione. Tutto questo implica l’attivazione e il consolidamento di relazioni affidabili, sia di tipo face to face sia di carattere digitale. Una ricerca triennale quanti-qualitativa su uno specifico contesto intersoggettivo costituito dalle parrocchie mette in luce quanto tali relazioni, interpersonali e digitali, siano entrate stabilmente nella vita quotidiana di ciascuno. L’indagine condotta evidenzia che attraverso tali relazioni, esperite sia in presenza sia attraverso il ricorso alle tecnologie digitali di comunicazione, le parrocchie generano forme specifiche di comunità che rappresentano luoghi fondamentali per i processi socio-educativi. Il tema educativo risulta oggi centrale nelle dinamiche sociali: i genitori e le famiglie possono in proposito costruire alleanze con altri adulti significativi, come gli educatori e i catechisti che operano nell’àmbito delle parrocchie, fronteggiando in tal modo l’odierna emergenza educativa non da sole, ma insieme ad altri adulti e creando efficaci sinergie socioeducative.
What happened during the pandemic period in terms of loneliness and social isolation has made us more aware of the importance of social relationships outside the family, both for the well-being of individual family members and for the entire nucleus. Building community areas and taking an active part in these processes is a crucial social task that families can carry out, thus contributing to the creation of social contexts that are attentive to people’s needs and in which it is possible to experience reciprocal and cooperative exchanges. All of this implies the activation and consolidation of reliable relationships, both face-to-face and digital in nature. A three-year quantitative-qualitative research on a specific intersubjective context constituted by parishes highlights how much these interpersonal and digital relationships have permanently entered everyone’s daily life. The survey conducted shows that through these relationships, experienced both in presence and through the use of digital communication technologies, parishes generate specific forms of communities that represent fundamental places for socio-educational processes. The educational theme is central today in social dynamics: parents and families can build alliances with other significant adults, such as educators and catechists who work in parishes, thus facing today’s educational emergency not alone, but together with other adults and creating effective socio-educational synergies.
Nell’àmbito delle scienze umane è nota da tempo e condivisa, con postura multi-prospettica, la complessità quale categoria ermeneutica entro cui la post-modernità si qualifica. Le vicissitudini trasformative – e non sempre migliorative – della famiglia tradizionale hanno configurato il reticolo relazionale dell’attuale compagine familiare. In tale contesto, finanche il benessere delle persone travalica i confini antinomici tra salute e malattia e si complessifica nello scambio dinamico con il contesto. La tradizione pedagogica di matrice montessoriana fonda l’urgenza attuale di ripensare il benessere personale in chiave bio-psico-sociale, a partire dalla cura della prima infanzia nel sistema familiare: «se prepareremo al fanciullo un ambiente in casa che sia confacente alle sue dimensioni, alle sue forze, alle sue facoltà psichiche, se ve lo lasceremo poi vivere liberamente, avremo fatto un grande passo verso la soluzione del problema educativo in genere, poiché avremo dato al bambino il suo ambiente».
Within the humanities, the hermeneutic category of the complexity qualifies post-modernity and is long known and shared. The transformative vicissitudes of the traditional family have configured the relational network of the current family. In this context, even people’s well-being transcends the antinomian boundaries between health and illness and is complexified in dynamic exchange with the context. The Montessori pedagogical tradition grounds the current urgency to rethink personal well-being from a bio-psycho-social perspective, beginning with early childhood care in the family system: «if we prepare for the child an environment in the home that is appropriate to his size, his strengths, his psychic faculties, if we then let him live there freely, we will have taken a great step toward solving the educational problem in general, for we will have given the child his environment».
IL VALORE DELL’ESPERIENZA
L’articolo propone un’analisi del fenomeno dei care leavers e del leaving care in Italia, ponendo un particolare focus sui processi di partecipazione e cittadinanza attiva dei giovani cresciuti “fuori famiglia” e sul ruolo che gli strumenti del racconto di sé e della narrazione collettiva, uniti da un forte legame di complementarità, hanno nell’attivarli e nel sostenerli.
The following paper offers an analysis of the care leavers and leaving care phenomenon in Italy, focusing specifically on the participation and active citizenship of young people who grew up outside their family circle and also on the role that self-telling and collective narrative – namely two complementary narrative devices – have in activate and supporting said processes.
The paper presents a collective and participatory research endeavour within the theatrical production “MoltiMe 2023 – Flash in Mob”. The primary objective of this research was to explore the role of art as a cultural phenomenon, in which the researchers assumed dual roles as participants and conductors1. Drawing upon the notion that cultures are inherently characterised by multiple identities, we interpret culture as an experience of relational and situated belonging. These affiliations are deeply embedded within lived relationships, constantly undergoing a process of mutual recognition, negotiation, and contestation. The researchers discuss the experience and performances engendered by their involvement, underpinned by the pedagogical intent of questioning the theatre project’s transformative influence.
Il contributo presenta un percorso di ricerca collettiva e partecipata all’interno della produzione teatrale “MoltiMe 2023 – Flash in Mob”. L’obiettivo primario di questa ricerca era esplorare il ruolo dell’arte come fenomeno culturale, in cui i ricercatori hanno assunto il doppio ruolo di partecipanti e conduttori. Partendo dal concetto che le culture sono intrinsecamente caratterizzate da identità multiple (Sökefeld, 2001), interpretiamo la cultura come un’esperienza di appartenenza relazionale e situata. Queste affiliazioni sono profondamente radicate nelle relazioni vissute, costantemente sottoposte a un processo di riconoscimento reciproco, negoziazione e contestazione. I ricercatori discutono l’esperienza e le performance generate dal loro coinvolgimento, sostenuti dall’intento pedagogico di mettere in discussione l’influenza trasformativa del progetto teatrale.
GESTIRE RELAZIONI
La conflittualità è sempre esistita perché in egual modo da sempre sono esistite le diversità. Più di ogni altro luogo al mondo è in famiglia che si impara a tollerarla, gestirla e apprezzarla, poiché è in essa che relazioni verticali e orizzontali si incontrano e si determinano reciprocamente. Parole, gesti, comportamenti segnano la quotidianità di ciascuno e ognuno li esterna in modo diverso in nome della propria unicità. La diversità diviene fonte di ricchezza personale e interpersonale solo quando si incontra il limite e ci si educa al confronto, imparando così a viverla con rispetto e tolleranza.
Conflicts have always existed as diversity existed in the same way. Family is the place where we learn to tolerate, manage and appreciate diversity, that environment where vertical and horizontal relationships meet each other and are mutually determined. Words, gestures, behaviours mark everyone’s daily life, and everyone expresses them differently in the name of their own uniqueness. Diversity becomes a source of personal and interpersonal richness only when limits are reached and one is educated to comparison, thus learning to live diversity with respect and tolerance.
Alla luce di un’ermeneutica gestaltica, il contributo inquadra il fenomeno dei gruppi di auto-mutuo-aiuto (AMA) nel loro contesto storico, nella loro specificità rispetto ad altre tipologie di percorsi in gruppo, nelle leggi intrinseche che ne scandiscono la vita interna e nelle fasi diacroniche che ogni iter attraversa. Queste vengono descritte e rilette secondo un’ottica originale che l’Autrice ha maturato nel corso della propria ultraventennale esperienza ed illustrate in un grafico. Per ognuna sono date indicazioni sul sostegno specifico che il trainer può dare. Seguono altri suggerimenti pratici per chi guida un gruppo AMA. Cardini del processo di auto-mutuoaiuto sono considerati la fiducia nel potere di autoregolazione e di potenziamento reciproco che il gruppo porta con sé, l’azione propulsiva verso il proprio benessere che l’attenzione agli altri con-partecipanti esercita, la certezza che l’essere umano nasce, cresce e procede attraverso relazioni e da relazioni sane può sempre essere aiutato e salvato.
Taking into consideration Gestalt hermeneutics, this paper places the experience of self-mutual-help groups (AMA) in their historical context. It comments on the uniqueness as compared to other types of group journeys, furthermore, it discusses the intrinsic laws that mark their internal life and in the diachronic phases that each process goes through. These are described and re-examined through an original perspective that the author has developed over the course of her over twenty years of experience and illustrated in a graph. For each, indications are given on the specific support that the trainer can give. Other practical suggestions for those who lead an AMA group follow. The trust in the power of self-regulation and mutual reinforcement that the group brings with it are looked upon as the cornerstones of the self-help process, the propulsive action towards one’s well-being that attention to other coparticipants exerts, the certainty that the human being is born, grows and proceeds through relationships and healthy relationships can always be helped and saved.
- ALESSIA TABACCHI
A. Potestio – E. Scaglia (eds.), Donne e lavoro nel Novecento. Sguardi di una pedagogia al femminile, Studium edizioni, Roma 2022
G. Romanazzi, Rinascere alla famiglia. Per una pedagogia generativa di competenze relazionali, FrancoAngeli, Milano 2022 - AVV. CARLO CASSANO
Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, Regolamento del Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati, Editrice Rotas, Trani 2023 - AGATA PISANA
E. Schininà, Noi voci invisibili, Le Château edizioni, Aosta 2022